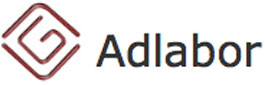Facebook, licenziamento e diritto di critica | ADLABOR
Illegittimo il licenziamento del dipendente che invia e condivide con i colleghi sulla chat di Facebook una vignetta avente contenuto lesivo e denigratorio per la società: così ha recentemente deciso la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2499 del 31 gennaio 2017.
Un lavoratore veniva licenziato, a seguito di procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970, per avere gravemente offeso l’immagine e il decoro aziendale, avendo pubblicato su una chat privata del social network Facebook, nella quale i colleghi di lavoro si scambiavano informazioni su un incontro sindacale per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, una vignetta avente contenuto lesivo dell’immagine della Società.
In particolare, la chat privata utilizzata dai dipendenti era stata intitolata “Vaselina day” e l’immagine postata dal lavoratore nella chat raffigurava un tappo di vasellina con impresso il marchio aziendale del gruppo di cui la Società datrice di lavoro faceva parte, una caricatura di un uomo di spalle con il dito medio puntato sul fondoschiena e la scritta “(nome del Gruppo societario, n.d.r.) Vaselina la trovi nei migliori outlet“.
Il lavoratore licenziato impugnava il recesso lamentando la mancanza di proporzionalità del licenziamento e la sua natura ritorsiva, adducendo che la risoluzione del rapporto era stata determinata esclusivamente dalla volontà di estrometterlo, dato che con la partecipazione attiva alla chat cercava di coinvolgere altri colleghi nella contestazione degli accordi sindacali aziendali che erano in fase di rinnovo.
Il Tribunale di Firenze, pronunciatosi sulla questione, nella fase sommaria annullava il licenziamento non ritenendo integrato il requisito della proporzionalità tra fatto contestato e il provvedimento disciplinare espulsivo che era stato adottato dal datore di lavoro.
La Società presentava opposizione nei confronti del provvedimento sommario, ma il Tribunale di Firenze con sentenza del 7.1.2014 (nr. 2/2014) rigettava l’opposizione proposta non ritenendo sussistente nel caso di specie alcun fatto di rilevanza disciplinare, e facendo invece rientrare la condotta del lavoratore nell’alveo dell’esercizio del diritto di critica e di satira.
La Corte d’Appello di Firenze avanti alla quale la Società ricorreva, con sentenza dell’11.4.2014 (nr. 401/2014), rigettava il reclamo del datore di lavoro e dichiarava addirittura la nullità del licenziamento, ritenendone integrata la natura ritorsiva.
La Suprema Corte adita dalla Società confermava definitivamente l’illegittimità del licenziamento, aderendo a quanto dedotto dalla Corte d’Appello di Firenze.
In particolare, la Suprema Corte con sentenza del 31 gennaio 2017 n. 2499 confermava la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto che l’addebito disciplinare rappresentasse un pretesto per allontanare il lavoratore -rientrato da appena un anno in esito ad un precedente contenzioso- che si era dimostrato, con la partecipazione attiva alla chat, per nulla remissivo alle iniziative datoriali sulla organizzazione del lavoro, cercando di coinvolgere altri colleghi nella contestazione nella fase di rinnovo degli accordi sindacali aziendali.
Ma ciò che probabilmente ha fatto propendere i giudici ad invalidare il recesso operato dalla Società è il fatto, sottolineato dalla Corte territoriale e avvalorato dalla Cassazione, che nel caso analizzato sarebbe assente un motivo legittimo di licenziamento.
È stato infatti ritenuto dalla sentenza che l’immagine pubblicata dal lavoratore sulla chat di Facebook sarebbe consistita in una vignetta satirica non dissimile alle rappresentazioni quotidianamente diffuse dai mass media e quindi di comune utilizzo e non lesiva del decoro.
Ulteriore elemento che la sentenza deduce per suffragare l’assenza di connotazione disciplinare del fatto contestato è che il disegno postato aveva ricevuto una diffusione limitata ai dieci colleghi del lavoratore licenziato che partecipavano alla chat: secondo i giudici l’accesso dall’esterno sarebbe rimasto quindi del tutto eventuale e legato ai contatti dei singoli aderenti alla chat, oltre al fatto che non era emerso che la vignetta avesse avuto una diffusione ulteriore sul web e che comunque potesse avere qualche interesse per il pubblico degli acquirenti del marchio aziendale.
L’elemento della ridotta diffusione dell’immagine, a parere dei giudici, avrebbe pertanto minimizzato il disvalore del comportamento del lavoratore.
Tuttavia, la decisione in commento non pare condivisibile per una serie di motivi.
In primo luogo si confonde l’inosservanza degli obblighi di correttezza, buona fede e civiltà che devono necessariamente sussistere nel rapporto di lavoro effettuando una forzata analogia con la satira televisiva o a mezzo stampa nella quale manca però un vincolo obbligatorio tra l’autore e il destinatario della satira, che invece è connaturato nel rapporto di lavoro.
Inoltre non appare invocabile, in un caso come quello di specie, il diritto di critica, che doveva essere rivolto nei confronti di scelte organizzative del datore di lavoro, mentre l’immagine pubblicata aveva un contenuto gratuitamente lesivo del decoro del datore di lavoro e dell’immagine del marchio aziendale.
Da ultimo, nemmeno è condivisibile l’argomentazione dedotta in sentenza secondo cui non sarebbe derivata, dalla condotta contestata al lavoratore, alcuna potenziale lesione dell’immagine aziendale stante la limitata diffusione della vignetta (tra i dieci partecipanti alla chat), visto anche il mancato accertamento della divulgazione dell’immagine all’esterno dell’ambiente di lavoro.
È evidente infatti che, perlomeno sotto il profilo potenziale, una vignetta con il contenuto dileggiante come quella postata dal lavoratore appare palesemente idonea a ledere il decoro dell’azienda e a metterla in ridicolo verso clienti, fornitori e concorrenti.
Si tratta quindi, a modo di vedere di chi scrive, di un’errata ed eccessivamente garantista interpretazione ad opera della giurisprudenza dell’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore che, come ha affermato anche la Cassazione, “.. seppur garantito dagli artt. 21 e 39 della Costituzione, incontra limiti nella correttezza formale e nel diritto, parimenti costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost., di tutela della persona, tanto da non poter prevalere sul contrapposto interesse alla reputazione ed all’onore del datore di lavoro. Qualora tali limiti vengano superati, con l’attribuzione all’impresa o ai suoi rappresentanti di appellativi disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione”. (Cass. 24 maggio 2001, n. 7091).
Tale principio per cui, non ogni espressione del pensiero, pur trattandosi di libertà fondamentale, è priva di limiti, è ben sintetizzabile nel famoso aforisma “La mia libertà finisce dove inizia la tua” che probabilmente nel caso oggetto della sentenza in commento è stato dimenticato.
A cura di Francesco Bedon